Nel cuore verde d’Italia: viaggio tra le nostre foreste
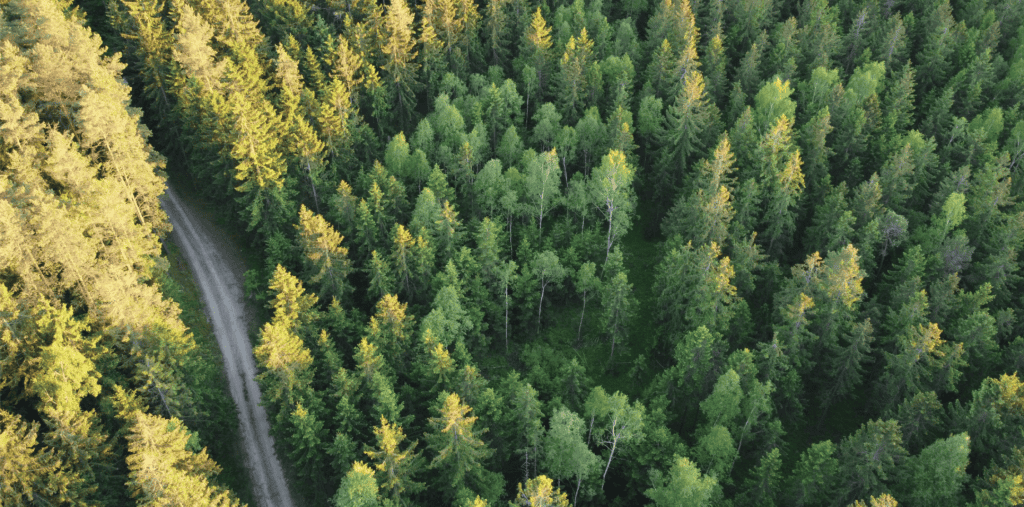
Nel cuore verde d’Italia: viaggio tra le nostre foreste
Con questa prima puntata inauguriamo una rubrica interamente dedicata alle foreste italiane, ecosistemi ricchissimi che modellano il paesaggio, assorbono CO₂, ospitano biodiversità e offrono benessere a chi li attraversa. In questo articolo abbiamo commentato alcuni dati e spunti emersi dal “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia”, per conoscere più da vicino questi mondi verdi spesso dimenticati, ma cruciali per il nostro futuro. Ogni episodio sarà un piccolo viaggio tra alberi, suoli, animali e strategie di adattamento, per imparare a leggere il bosco con occhi nuovi.

Nel cuore verde d’Italia: viaggio tra le nostre foreste
Con questa prima puntata inauguriamo una rubrica interamente dedicata alle foreste italiane, ecosistemi ricchissimi che modellano il paesaggio, assorbono CO₂, ospitano biodiversità e offrono benessere a chi li attraversa. In questo articolo abbiamo commentato alcuni dati e spunti emersi dal “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia”, per conoscere più da vicino questi mondi verdi spesso dimenticati, ma cruciali per il nostro futuro. Ogni episodio sarà un piccolo viaggio tra alberi, suoli, animali e strategie di adattamento, per imparare a leggere il bosco con occhi nuovi.

Dove si trovano le foreste italiane? Un mosaico verde in espansione
Secondo i dati raccolti nell’ultimo “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia” le foreste italiane occupano oltre 11,4 milioni di ettari, pari al 38% del territorio nazionale, e sono in costante espansione. Questo aumento, stimato in quasi 75.000 ettari all’anno, è dovuto principalmente al progressivo abbandono delle terre agricole marginali, soprattutto in zone collinari e montane, dove la pressione antropica si è notevolmente ridotta nel corso del Novecento.
La distribuzione non è omogenea: oltre il 70% delle superfici forestali si concentra nelle regioni montane, in particolare lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica. Le regioni più boscate sono:
- Toscana con circa 1,2 milioni di ettari,
- Piemonte (oltre 900.000 ettari),
- Trentino-Alto Adige (circa 800.000 ettari),
- Lombardia ed Emilia-Romagna, entrambe con ampie estensioni, soprattutto a ridosso delle aree prealpine e appenniniche.
Ma il verde non si ferma alla montagna: foreste planiziali come quelle del Parco del Ticino, del Delta del Po o delle piane toscane e laziali rappresentano veri e propri scrigni di biodiversità, spesso relitti di un passato in cui le grandi pianure erano coperte da querce, olmi, pioppi e frassini. Questi ambienti sono oggi tra i più rari e vulnerabili, ma fondamentali per il ruolo ecologico che svolgono in termini di filtraggio delle acque, contenimento delle alluvioni e corridoi faunistici.
Dalle faggete delle Alpi e degli Appennini, spesso site in aree protette o riconosciute come patrimonio UNESCO, ai querceti collinari e alle leccete costiere del Sud e delle isole, le foreste italiane si configurano come un mosaico di habitat diversificati, modellati dalla geografia, dal clima e anche da secoli di presenza umana.
Quanti e quali tipologie di habitat forestali esistono?
La classificazione europea degli habitat naturali ci aiuta a comprendere l’enorme varietà delle foreste italiane: sono 29 i tipi di habitat forestali riconosciuti in Italia dalla Direttiva Habitat, di cui 6 considerati prioritari per la conservazione per la loro rarità e vulnerabilità. Questa tipologia si articola in:
- Foreste di latifoglie temperate, come le faggete appenniniche o i querceti mesofili;
- Foreste mediterranee, come leccete, sugherete e boschi a sclerofille sempreverdi;
- Foreste montane e boreali, ad esempio le abetine alpine, i lariceti e i cembreti.
Ogni habitat rappresenta un equilibrio dinamico tra specie vegetali e animali, condizioni climatiche, geologia e uso storico del suolo. Alcuni ecosistemi forestali – come le faggete vetuste – si sono sviluppati in condizioni di relativa stabilità ecologica e ospitano processi naturali complessi. Altri, invece, sono il risultato di pratiche antropiche, come disboscamenti, rimboschimenti artificiali o coltivazioni boschive, e oggi sono oggetto di interventi di rinaturalizzazione e gestione ecologica per ripristinarne la biodiversità e la funzionalità ambientale.
I protagonisti silenziosi della biodiversità
Le foreste italiane sono autentici scrigni di biodiversità, veri e propri ecosistemi rifugio che custodiscono un patrimonio biologico straordinario. Si stima che circa il 65% delle specie terrestri presenti in Italia sia legato agli ambienti forestali, rendendo i nostri boschi fondamentali per la conservazione della vita. Tra il fitto degli alberi, nel suolo, nei tronchi in decomposizione e tra le chiome, vivono migliaia di specie: mammiferi, uccelli, insetti, rettili, anfibi, ma anche funghi, muschi e licheni.
Esemplari emblematici non mancano: il lupo appenninico, una specie tornata a colonizzare ampie aree del centro-nord Italia, simboleggia la resilienza della natura in ambienti a lungo antropizzati. Il picchio nero e il gufo reale sono ospiti delle faggete più vetuste, dove il legno morto, spesso visto come un residuo inutile, diventa invece risorsa e riparo per numerose specie. Nei boschi più integri troviamo coleotteri saproxilici, come Rosalia alpina, che svolgono un ruolo chiave nei cicli di decomposizione, restituendo nutrienti al suolo.
Ma non c’è solo fauna: le foreste ospitano anche una ricchissima flora forestale. Nelle radure, negli anfratti e nei microhabitat fioriscono orchidee spontanee, felci relitte e specie vegetali endemiche che resistono in condizioni ambientali spesso uniche.
La biodiversità forestale non è solo una questione estetica: è una riserva di stabilità ecologica. Più un bosco è ricco di specie, più è capace di affrontare malattie, incendi, cambiamenti climatici. Per questo conservarla significa investire nel futuro degli ecosistemi e nel nostro.
Boschi intelligenti: come funziona la vita segreta della foresta
Camminare in un bosco può sembrare un’esperienza tranquilla e silenziosa, ma ogni metro quadrato nasconde un incredibile intreccio di relazioni biologiche. Gli alberi non vivono isolati: attraverso le micorrize, reti sotterranee formate da funghi simbionti, condividono nutrienti, acqua e segnali chimici, supportandosi a vicenda. In superficie, la chioma degli alberi regola l’umidità, la luce e la temperatura, creando condizioni ideali per molte altre forme di vita.
A comprendere e gestire questi processi ci pensa la selvicoltura, disciplina che oggi va ben oltre la produzione di legname. Una moderna gestione forestale si occupa della rigenerazione naturale, del mantenimento delle specie autoctone, della riduzione del rischio incendi e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Secondo i dati del RAF 2019, il 60% delle superfici forestali italiane è oggi oggetto di forme di gestione, seppur con intensità e finalità molto variabili.
Ogni tipo di bosco racconta una storia di equilibri ecologici: nei castagneti abbandonati, ad esempio, le piante pioniere lasciano il posto a specie più esigenti come il faggio, mentre nelle sugherete mediterranee una mancata gestione può favorire l’invasione di specie arbustive, degradando l’habitat. In altri casi, alcune specie, come l’abete rosso in certe zone degli Appennini, sono frutto di rimboschimenti passati e oggi richiedono interventi di diversificazione per accrescere la resilienza.
In questo scenario, la sfida è chiara: conciliando le esigenze ecologiche con quelle economiche e sociali, è possibile custodire un patrimonio naturale vitale per la salute del pianeta.
La risposta di Robin Wood
Per far fronte a queste sfide è necessario promuovere un cambio di passo: serve una gestione sostenibile, multifunzionale e condivisa, capace di riportare attenzione, risorse e cura nei territori boschivi. Per farlo, è fondamentale coinvolgere tutti gli attori locali – comunità, imprese, istituzioni – attraverso pratiche di selvicoltura mirata, progetti di valorizzazione e strategie che guardino al lungo periodo. È proprio su queste basi che nasce Robin Wood, un’iniziativa che mette in relazione aziende attente alla sostenibilità con le foreste che più necessitano di interventi. Un ponte concreto e trasparente tra chi cerca di ridurre il proprio impatto ambientale e chi lavora ogni giorno per tutelare e rigenerare gli ecosistemi forestali. Il risultato? Un beneficio reale per il territorio, la biodiversità e le persone che lo abitano.
Prendiamoci cura del futuro insieme
Come abbiamo visto, l’associazionismo fondiario è in grado di risvegliare un senso di appartenenza e di responsabilità condivisa. È un modo per guardare al futuro, mettendo insieme innovazione e tradizione, ecologia e sviluppo, tecnologia e radici. Attraverso una gestione collettiva, partecipata e lungimirante, il territorio diventa risorsa viva, non solo per chi lo abita oggi, ma anche per le generazioni che verranno.
L’associazionismo fondiario è, in fondo, un invito: a non lasciare andare ciò che abbiamo ereditato, ma a prendercene cura insieme, trasformando il paesaggio in un bene comune da custodire e valorizzare.
Il progetto Robin Wood si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo soluzioni concrete per la gestione sostenibile delle risorse naturali e la riforestazione. Attraverso la collaborazione con comunità locali e aziende, Robin Wood promuove azioni di recupero ambientale, contribuendo a contrastare il cambiamento climatico e valorizzando il territorio in modo responsabile e duraturo.
Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con Robin Wood
Robin Wood si ispira alle migliori pratiche internazionali e ai principi delle principali iniziative globali per promuovere una gestione forestale sostenibile. Il suo approccio è focalizzato sulla custodia degli stock di carbonio e sulla tutela della biodiversità forestale, elementi essenziali per combattere il cambiamento climatico e preservare l’ambiente. Sebbene le azioni di Robin Wood ad oggi non costituiscano crediti di carbonio certificati, i loro impatti positivi sono misurabili e contribuiscono in modo tangibile a supportare le strategie aziendali orientate alla sostenibilità. Attraverso pratiche di gestione forestale responsabile, Robin Wood aiuta le aziende a ridurre l’impronta ecologica, a proteggere la biodiversità e a promuovere un’economia sostenibile a lungo termine.
